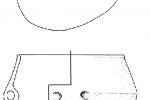Canelles
Lo studio degli insediamenti preistorici della Sardegna è stato negli anni limitato dalla problematicità dei dati disponibili, quali la diffusione eterogenea, con cospicui ritrovamenti nella Sardegna centro-meridionale a fronte di una più limitata presenza nel Nord dell'isola, che, al contrario, registra una maggiore concentrazione di ipogei funerari. Un altro limite è la provenienza di gran parte delle informazioni da raccolte di superficie non sistematiche. A ciò si aggiungono l'edizione spesso parziale dei dati di scavo e l'impostazione non interdisciplinare delle ricerche. Dunque se gli abitati preistorici da un lato rappresentano una fondamentale risorsa per la comprensione dei contesti culturali, dell'organizzazione sociale ed economica dei gruppi umani, della loro interazione con il territorio e delle loro relazioni con comunità esterne, dall'altro costituiscono un terreno di analisi complesso per la qualità spesso mediocre dei dati di partenza e per la frequente assenza di emergenze monumentali; ciò ha spesso comportato la difficile identificazione delle aree d'abitato o la loro cancellazione a causa della frequentazione antropica moderna.
Per l'Ozieri e il Sub-Ozieri due siti si distinguono per essere stati oggetto di scavo estensivo, Su Coddu-Selargius e Cuccuru S'Arriu-Cabras, entrambi pubblicati solo parzialmente e con metodologie di scavo eterogenee.
L'intervento dell'Università di Sassari in un settore dell'insediamento di Su Coddu, area Canelles, lotto Badas, effettuato tra il 2001 e il 2007 nel quadro di un programma di collaborazione con la Soprintendenza archeologica, ha fornito l'occasione per l'approfondimento di un progetto di ricerca pluriennale interdisciplinare dell'Università di Sassari, diretto da Maria Grazia Melis, dal titolo Archeologia degli insediamenti preistorici della Sardegna, finalizzato alla ricostruzione del quadro ambientale e socio-economico delle prime comunità eneolitiche sarde. L'eccezionalità del contesto e la possibilità di effettuare un'indagine che esulasse dai caratteri dell'intervento d'urgenza cui la parte restante dell'insediamento è soggetta, ha consentito l'applicazione di un approccio metodologico innovativo per la Sardegna, che ha richiesto una più lunga attività sul campo ma ha consentito già nei risultati preliminari di colmare alcune lacune e meglio interpretare le conoscenze già acquisite.
ASPETTI METODOLOGICI E RISULTATI PRELIMINARI
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi l'analisi della produzione artigianale, gli studi dell'insediamento in relazione all'ambiente naturale, i dati cronologici, l'archeologia sperimentale e l'analisi dei dati architettonici. Questi settori della ricerca non sono considerati indipendenti ma interagiscono fra loro e tutti concorrono agli obiettivi generali.
Produzione artigianale
L'analisi della produzione artigianale è portata avanti con un approccio originale per la Sardegna, che mira non solo alla ricostruzione delle sequenze operative di ciascuna produzione, ma anche all'interazione fra esse. In generale la produzione artigianale Sub-Ozieri di Selargius mostra un impiego del savoir faire tecnologico limitato ad alcune categorie di manufatti.
Insediamento e ambiente naturale
L'analisi dei dati geografici consente di inquadrare il villaggio in un tipo insediativo ben attestato sin dall'Ozieri, caratterizzato da un paesaggio sub-pianeggiante su sostrato alluvionale, con suoli a vocazione agricola, nelle vicinanze di un corso d'acqua e di una zona umida.
Al fine della ricostruzione degli aspetti paleoecologici e paleoeconomici, particolarmente carenti nella letteratura prenuragica, tutte le unità stratigrafiche sono state campionate per le analisi archeobotaniche, archeozoologiche e chimico-fisiche, affidate rispettivamente ad Alessandra Celant, Marco Zedda e Paolo Mulè. I risultati preliminari delle analisi chimico-fisiche sono stati già utilizzati per varie finalità, dall'elaborazione dei dati radiocarbonici, alla rimozione delle incrostazioni delle ceramiche, allo studio dei fenomeni postdeposizionali. Tutti i dati qui elencati concorrono inoltre allo studio dell'uso del territorio, mentre alcune considerazioni, pur parziali, sono state effettuate sugli aspetti topografici della porzione di abitato esaminata, in particolare in relazione alle strutture e agli spazi esterni.
Cronologia
Sono state recentemente pubblicate (Melis et alii 2007) le datazioni provenienti dal lotto Badas, le sole disponibili attualmente per il Sub-Ozieri, se si escludono quelle problematiche di Monte d'Accoddi e quelle di ambito funerario di Cannas di Sotto-Carbonia. Di particolare interesse la datazione proveniente dalla struttura 134, intermedia tra l'Ozieri e il Sub-Ozieri, così come i caratteri morfo-tecnologici dei materiali cui si riferisce (Melis e Piras 2012). Ciò riveste una considerevole importanza poiché testimonia la gradualità del passaggio dall'Ozieri al Sub-Ozieri. In altri termini il processo di trasformazioni e la "crisi" della metà del IV millennio, attestata in diverse zone europee in Sardegna sembra seguire un percorso lento, con una tendenza alla perdita del senso estetico nella produzione artigianale e nelle architetture (es. Monte d'Accoddi).
Archeologia sperimentale
La verifica sperimentale è stata ed è un prezioso strumento per l'interpretazione delle tracce tecniche e delle tracce d'uso rilevate nei materiali di Selargius.
Architettura
Nel campo dell'architettura l'indagine stratigrafica e l'analisi dei dati morfologici hanno consentito di individuare la funzione o le diverse funzioni delle sottostrutture: ambienti abitativi con focolare interno, silos, strutture di combustione, depositi per rifiuti, buche per palo. Lo studio sull'impiego dell'argilla cruda ha portato un contributo importante seppur nei suoi risultati ancora preliminari. Noto da brevi notizie sui precedenti interventi di scavo diretti da Ugas, l'uso dell'incannucciato, dei mattoni e dell'intonaco è ben documentato nel lotto Badas: i mattoni d'argilla, rinvenuti in giacitura secondaria, erano presumibilmente utilizzati sia come materiale da costruzione sia, forse, come materia prima per la produzione della ceramica. Le analisi archeometriche condotte da Paola Mameli sull'intonaco (Mameli e Melis 2008), del quale si conserva anche qualche frammento dipinto, hanno consentito di ben caratterizzare i frammenti, che mostrano analogie con gli intonaci di Monte d'Accoddi e sembrano costituire l'esito, non sappiamo se intenzionale, del probabile uso di alcune buche come strutture di combustione.
La ricostruzione del quadro ambientale e socio-economico
La carenza di dati paleocologici lamentata per la Sardegna costituisce un limite alla ricostruzione dei rapporti tra l'uomo e l'ambiente naturale e all'individuazione dei fattori che possano aver condizionato l'organizzazione socio-economica. I primi risultati della ricerca hanno contribuito a meglio definire molti ambiti quali la cronologia e l'architettura. In particolare la trasformazione della produzione artigianale rappresenta un campo di approfondimento importante, finora non ben enucleato: da un lato si è evidenziata l'evoluzione graduale dall'Ozieri al Sub-Ozieri, confermata dai dati radiometrici; dall'altro è comprovata una mutata organizzazione della produzione artigianale rispetto al Neolitico Ozieri, condizionata dalla necessità di ridurre i tempi della produzione. Tra i fattori che possono aver influenzato tali necessità possiamo proporre a titolo di ipotesi le prime esperienze nel campo della metallurgia e forse un maggiore sviluppo dell'agricoltura, che sembra indiziato dalla presenza di silos, vasi per la conservazione delle derrate etc. (Melis 2009). Questo troverebbe conferma nelle innovazioni tecnologiche in campo agricolo che solitamente accompagnano gli sviluppi dell'Eneolitico ed inoltre nei risultati, seppur ancora limitati, delle analisi degli isotopi stabili di carbonio e azoto su resti scheletrici sardi, che indicherebbero nell'Eneolitico una dieta più vegetariana rispetto al Neolitico, confermata anche dalle analisi archeozoologiche del lotto Badas.